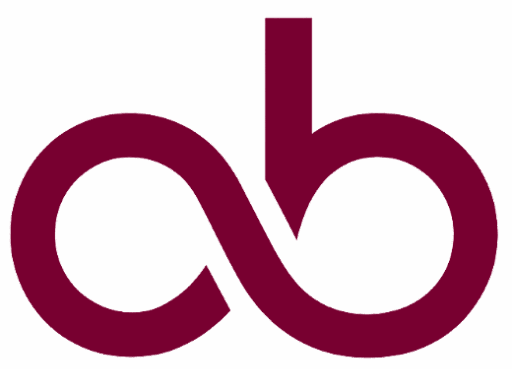Vermeer. Il silenzio luminoso di Delft
Osserviamo un dettaglio della famosa Veduta di Delft (1660-1661): una sciarada visuale composta da donne, due pali d’ormeggio e un piccolo gruppo di persone, probabilmente mercanti di fronte al battello dei loro traffici. Le due donne sulla riva sono immerse in una luce dorata di salvezza, avvolte dal suo velo di serena trasparenza e grazia.
Benedette dalla luce, e separate dal resto della scena come figure di un altro tempo, o di un altro destino.
I pali d’ormeggio e il riflesso verticale del campanile sono punti fermi che separano le due sorti mentre il fiume della vita scorre tra le due rive. Per contrasto, dietro i mercanti incombe l’ombra scura della ventura avversa, del rischio, della rovina, e in parte ne sono già investiti. In una tela che pare fissata in un momento di staticità assoluta, il 60% della superficie è disegnata dal cielo e un altro 15% dal fiume, la scena lievita nel fluire dell’aria, dell’acqua, del tempo. È solo la luce a sciogliere l’enigma nascosto dietro una apparente semplicità compositiva.

Johannes van der Meer visse nella tranquilla, opalescente luce di Delft, una città tagliata da canali che riflettono il cielo basso d’Olanda. Non fu un pittore di grandi gesti o di biografie tempestose, dipinse tele ove regnano la calma, il mistero e una perfezione silenziosa, costruite in interni raccolti, stanze nella quali il tempo è sospeso e l’unico accadere è quello della luce che incontra gli ambienti e gli oggetti.
In una Delft del 1632, che univa prosperità mercantile, tensioni religiose e una sorprendente vivacità culturale, Vermeer, figlio di un tessitore di seta che si reinventò commerciante d’arte e locandiere, visse con la famiglia tra la locanda “Mechelen”, affacciata sul mercato, e una piccola attività di compravendita di dipinti. Tra locanda e bottega, il giovane Jan ebbe modo di avere un primo accesso alle reti artistiche della città, ma anche alle voci, alle contrattazioni e alle liti, ai gusti mutevoli dei collezionisti: un ambiente modesto ma immerso in un modi e maniere che avrebbero segnato la sua formazione.
Fino a ventun’anni, quando sposa, per amore e in gran segreto, Catharina Bolnes, di ambiente sociale e religioso molto diverso dal suo. Dal matrimonio, nacquero quindici figli, dei quali undici sopravvissero all’infanzia. Le nozze, cui corrispose anche un atto di convinta conversione al cattolicesimo, lo inserirono in una rete familiare solida, dominata dalla figura autorevole, benestante e molto influente della suocera, Maria Thins, da poco separata dal marito violento.
Dopo il matrimonio, Jan e Catharina vanno a vivere in casa Bolnes, in Oude Langendijk, nel cuore del quartiere cattolico clandestino, a contatto con i gesuiti attivi nella zona di Schipluiden, parte di un gruppo numeroso di fedeli, costretto a praticare la propria fede in case private e cappelle nascoste, le schuilkerken, sorvegliate, con discrezione, dalle autorità, in un’Olanda che riconosceva ufficialmente solo il culto calvinista.
Ebbe forse modo di incontrare Spinoza, frequentatore a Rijnsburg, a pochi chilometri da Delft, del circolo dei “Collegianti”, un movimento cristiano non dogmatico che predicava tolleranza e libertà di discussione, in una Repubblica d’Olanda che, pur attraversata da forti tensioni confessionali, era comunque uno dei luoghi in Europa più aperti allo studio e alla circolazione delle idee.
Pochi mesi dopo il matrimonio, potendo soddisfare le richieste di ammissione – formazione artistica, pagamento di una non trascurabile quota d’ingresso, consona posizione sociale – entra come maestro pittore alla Gilda di San Luca, per divenirne poi sindaco. Non propriamente un esordiente nel mondo dell’arte quindi, ma la fama e il successo gli sfuggono. Non riesce, o non vuole, coglierne i frutti.
Nelle prime opere dipinge soggetti biblici di ampio respiro, opere nelle quali già si intravede un interesse per l’intimità dell’incontro. Rivolge presto lo sguardo altrove: quieti spazi domestici, stanze dove il tempo è sospeso – spazi interni come spazi interiori. Una donna che versa il latte, una che scrive una lettera e un’altra a cui una lettera viene letta, un volto assorto che si illumina accanto a una finestra: pittura dei gesti minimi, quadri di scene in cui non accade nulla. Tele dalla psicologia sussurrata. Stanze come teatri minimi in cui solo la luce è protagonista, una luce che sospende il tempo. Trascendente? forse, o puro momento contemplativo e, insieme, invito a fermarsi, pensare: riflettere. Luce che è anche unico frammento trasposto del mondo esterno, di cui arriva solo il riflesso e nessun bagliore. Come delle lettere non abbiamo il contenuto, della vita reale dei protagonisti abbiamo solo l’enigma: dove vivono, su quale piazza affaccia la finestra, chi attenda la donna, chi è il fruitore della musica? Lo spettatore da osservatore diviene sceneggiatore, può raccontare la storia, o una storia. Si pone domande, tenta risposte che pongono altre domande. Qui voleva forse infine arrivare Vermeer?
Eppure non può essere coincidenza che in molte tele sia centrale una lettera – l’attesa della buona novella – e che in tutte le opere l’apposizione della luce regoli il comporsi della scena. Elementi immediatamente comprensibili ai destinatari e committenti delle opere, sfuggenti per l’osservatore non coinvolto nelle segrete tesi.

Lavora con lentezza ascetica, non più di due o tre opere all’anno, distillati di luce e pensiero. In un’Olanda del Seicento attraversata da un barocco esuberante, frenetica di commerci e tensioni, Vermeer non si muove dal suo studio al primo piano della casa in Oude Langendijk, affacciata sul corso. Gli basta un raggio di luce: una luce selettiva, che non illumina tutto: accarezza la curva di una brocca, fa brillare un filo di perla, si posa su una guancia, lascia in penombra gli angoli della stanza. Luce che modella il silenzio. Le famose “piccole perle di luce”, i punti luminosi che punteggiano oggetti e vestiti, sono la sua firma ottica, quella di un osservatore che sa catturare le vibrazioni di un attimo emotivo.
Astrazione o distrazione da una vita segnata dalle preoccupazioni finanziarie? Eppure utilizza una tavolozza preziosa: l’oltremare naturale, ricercato come l’oro, il giallo di piombo e stagno, il rosso cinabro, il verde malachite, pigmenti che, in velature sovrapposte, donano al dipinto profondità e luminosità, il famoso “giallo Vermeer”: colore che solidifica la luce.
La famiglia numerosa, un’attività lenta e costosa, l’anno disastroso del 1672 e la conseguente paralisi del mercato dell’arte segnano definitivamente una vita vissuta perennemente in posizione economica precaria. Morì a 43 anni, nel 1675, lasciando debiti e una moglie straziata.
La sua fama, già circoscritta a una ristretta cerchia di intendenti locali – le sue opere circolavano, a poco prezzo, tra poche committenze locali, e la sua posizione nel mercato dell’arte rimase sempre nascosta, secondaria – svanì rapidamente, poco più di un nome in antichi registri, nome che per due secoli si perse nell’oblio; fino al saggio del 1866 di Théophile Thoré-Bürger che lo restituì al mondo.

Un successo che divenne poi esaltazione, ossessione, infatuazione: da Wilhelm Hammershøi a Edward Hopper, Stanley Kubrick, Marcel Proust – la Veduta di Delft al Jeu de Paume, il quadro più bello del mondo e la piccola parte di muro giallo, l’ultimo sforzo per il quale il grande scrittore trovò la forza di uscire di casa. E poi: la fotografia moderna, i temi della la luce come rivelatore emotivo, l’iconografia dell’attesa e della solitudine, il surrealismo, il realismo magico e l’iperrealismo, il silenzio come presenza attiva, la geometria dell’attesa, la psicocromia e l’alienazione moderna, l’ermeneutica degli spazi vuoti: sembra che tutto il Novecento passi da Delft, Novecento su cui Vermeer riflette la sua luce. Luce, luce, ancora luce.